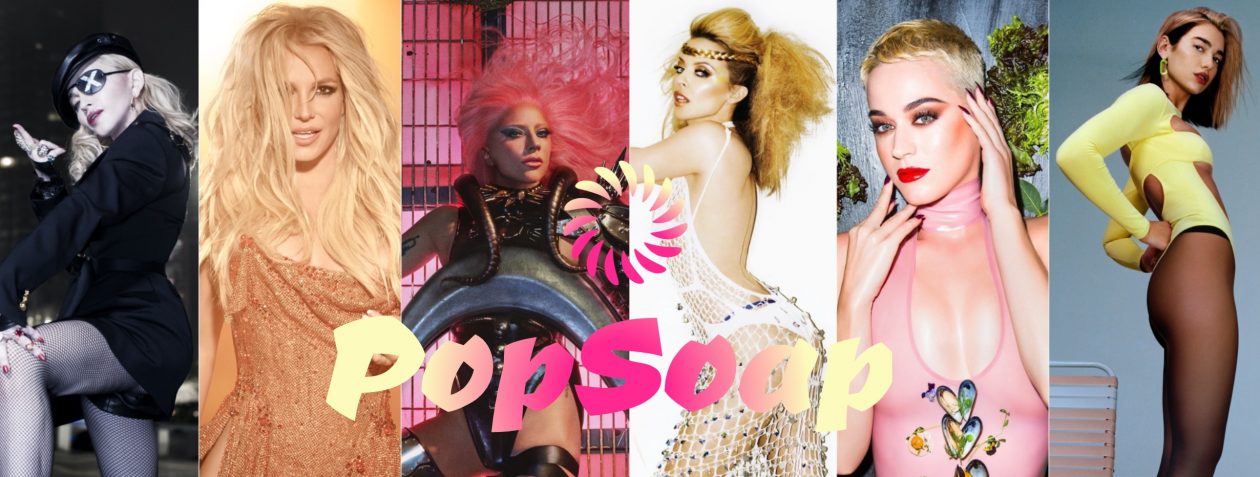Quando abbiamo intrapreso la stesura di questa recensione e badato al mormorìo che Lemonade, il nuovo progetto audiovisivo di Beyoncé ha alimentato, tre quesiti ci sono balzati in mente:
1) Beyoncé è stata tradita dal marito Jay Z e sente il bisogno di espletarlo in musica?
2) L’intero album, appena uscito, parla quindi di infedeltà e mette Jay Z alla berlina?
3) C’è una quanto meno sottesa voglia di lucrare su una vicenda così personale?

Dopo aver risposto positivamente a tutte e tre le domande, abbiamo ascoltato l’ultimo disco della diva texana, cercando di focalizzare l’attenzione sulla qualità dei brani in esso contenuti e sui testi, oltre a guardare il lungometraggio che lo supporta visivamente, e abbiamo dedotto che, a prescindere dal guadagno e dall’indubbia tattica commerciale, Lemonade è molto più che il resoconto di un matrimonio disturbato da tresche, molto più che una sceneggiata napoletana à la Isso, essa e ’a malamente.
Questo disco è una catarsi interiore divisa in più stadi, in cui si parte dalla delusione, dalla rabbia e dalla perdita di certezze per poi giungere alla redenzione, al recupero di un amore e al perdono, pur sempre dosato, concesso da Beyoncé tenendo conto del principio etico Forgive, but do not forget.
A noi non è dato sapere se si tratti di fiction o se l’album sia frutto di un’esigenza genuina, anzi, nemmeno ci interessa indagare. Quello che ci stupisce, soddisfacendoci, è notare come Beyoncé abbia con il suo sesto opus discografico portato a un livello superiore il binomio video/canzone a cui ha sempre, fin dagli esordi della carriera da solista, attribuito un valore essenziale.
La surprise release, a questo giro, è risultata un tantino più prevedibile rispetto a quella fredda notte di Dicembre 2013 in cui il disco eponimo si materializzò nella sua completezza su iTunes, sbucando ovunque dal nulla: Lemonade è stato preceduto da tweet e spot trasmessi dal canale americano via cavo HBO e da un trailer che dava appuntamento alla sera del 23 Aprile scorso per la messa in onda, in prima visione, del film. Era dunque inevitabile che qualcosa sarebbe apparso su TIDAL qualche minuto più tardi, e così è accaduto.
L’album, tuttavia, non si rivela semplicemente visuale: stavolta è conceptual, musica e immagini seguono una trama, raccontano e ritraggono uno scorcio di vita lungo 12 inediti (più o meno privato) che esamineremo con la nostra lente.
La limonata servita dalla Knowles va dunque bevuta con calma, addolcita con un solo cucchiaio di zucchero, affinché mantenga il suo sapore acre, esattamente come il metaforico proverbio che ha ispirato la scelta del titolo lascia intendere (’When life gives you lemons, make lemonade’).
Andiamo dritti al punto:
Pray You Catch Me apre la raccolta in punta di piedi, con la nostalgia tipica delle ballate pianistiche rese solenni dalla carezza degli archi, ma a conquistare subito l’orecchio è la fragilità emotiva sparsa tra soavi armonie R&B/soul che tradiscono, con garbo, sentimenti di sospetto e diffidenza nutriti verso il comportamento del proprio amante (’You can taste the dishonesty / It’s all over your breath, as you pass it off so cavalier’). Curiosamente, una prima versione di questo pezzo risulta depositata due anni fa dalla Roc Nation, ormai nota compagnia/casa discografica fondata da Jay Z, e include Kevin Garrett come unico autore e interprete del brano (la qual cosa ci spinge a credere che Beyoncé abbia ascoltato il provino originale e ne sia rimasta talmente colpita da volerlo rimaneggiare per il nuovo album, insieme a James Blake). (8/10)
Hold Up, coscritta da Father John Misty con un piccolo contributo sul bridge da parte di MNEK, è una traccia imbevuta di elementi reggae nella quale Beyoncé gareggia (guarda caso) con la mai stata amica Rihanna a suon di ritmi estivi e midtempo, trombe da stadio e cadenze giamaicane, reclamando al proprio uomo il primato in ambito sentimentale. La canzone, a giudicare dai 15 nomi presenti nei credits, è una sorta di Frankenstein nato sotto forma di demo da un minuto circa nel 2014, per mano di Diplo e di Ezra Koenig, leader dei Vampire Weekend, man mano assemblato e limato dagli altri parolieri tramite dettagli aggiunti e astuta combinazione di samples tratti dai brani più disparati e inconciliabili.
Le corde in pizzicato da Can’t Get Used To Losing You (1963) di Andy Williams, sommerse nella base, rappresentano così lo scheletro sul quale l’intera produzione si poggia fin dal principio, mentre parte del refrain (distinto da una melodia discendente) proviene da Maps del trio Yeah Yeah Yeahs, uscita nel 2003. L’outro riprende invece il verso iniziale da Turn My Swag On (2008) del rapper Soulja Boy.
Testualmente parlando, non ci sono più dubbi: Beyoncé ha appena subodorato qualcosa di losco e lo dichiara senza mezzi termini (´Something don’t feel right, because it ain’t right / Especially comin’ up after midnight / I smell your secret and I’m not too perfect to ever feel this worthless´). (6/10)
Don’t Hurt Yourself ufficializza il ritorno di Sasha Fierce (alter ego ideato da Bey per dare forma e voce all’aspetto più aggressivo e spocchioso della propria personalità, con l’album del 2008). La signora Carter, al pari di una Furia persecutrice, dà sfogo a tutta la collera serbata nei riguardi del coniuge adultero, e la esterna con il supporto di un organo elettrico dal riff istantaneo, la batteria dei Led Zeppelin, chitarre dal graffio grunge e le parole più esplicite e crude che esistano per colpire un maschio alpha nell’orgoglio (’Who the fuck do you think I am? / You ain’t married to no average bitch, boy / You can watch my fat ass twist, boy / As I bounce to the next dick, boy’). (6/10)
Sorry, inizialmente prodotta dall’emergente e del tutto ignoto al grande pubblico MeLo-X e successivamente rielaborata dal più celebre e acclamato Hit-Boy, è una delle canzoni più radiofoniche dell’intero LP, nonché quella in cui la superstar risente in modo palese dello stile vocale che ha reso talentuosa la poliedrica Wynter Gordon, autrice del brano. Guidato da una synth line abbastanza comune in generi quali la musica trance e la dancehall (non è una coincidenza il fatto che ne venga usata una simile anche come intro per Unapologetic Bitch di Madonna) e da incalzanti sonorità trap/electro che subiscono un rallentamento e sfociano nell’industrial verso la chiusura della traccia, il pezzo è un impenitente dito medio alzato contro il fedifrago Jay Z e un’ode al Girl Power. Anche qui, il tema del tradimento costituisce il cardine attorno a cui il testo ruota (’Today I regret the night I put that ring on’), e stavolta ritroviamo persino un nome: un misterioso motteggio, ’He better call Becky with the good hair’, con cui viene bollata l’anonima rivale in amore della Knowles (che tanto clamore sta suscitando in questi giorni sul web, a causa della sua incerta identità). (8/10)
Dopo tanta ira, è tempo di pensare a quanto una donna indipendente abbia il sacrosanto diritto di proclamare la propria emancipazione (e la propria rivincita) dall’alto dei tacchi a spillo che ama indossare; in 6 Inch, attesissima collaborazione con The Weeknd, curata da BOOTS, il mood è sensuale, pregno di intrigo, accentuato da un drumbeat dalle vibrazioni cupe e da richiami al trip hop anni ’90. Durante l’inciso il cantato è reso ancora più accattivante dall’autotune, ma la parte vincente giace nel bridge, impreziosito da un superbo intreccio di melodie malinconiche (’Oh, stars in her eyes / She fights and she sweats those sleepless nights / But she don’t mind, she loves the grind / She grinds from Monday to Friday, works from Friday to Sunday, yeah, yeah’), a cui segue un quasi afono ’come back’ intonato a più riprese sul finale.
Pur di evitare querele per plagio, la Knowles e il suo team si sono preoccupati bene di creditare chiunque in 6 Inch, addirittura brani che condividono, per accidente, porzioni di testo analoghe. (7/10)
Con Daddy Lessons, altro testo firmato da Wynter Gordon, la musica country pura e incontaminata (priva di breakdown à la Avicii e colleghi, per intenderci) viene riportata da Beyoncé alle origini, per la gioia di tutti quei musicologi che vincolano gli albori di questo genere alla cultura africana, e quindi alla razza nera. La canzone, sostenuta da un vivace arrangiamento bluegrass che non manca di strizzare l’occhio al jazz (merito dell’assolo di sax suonato dal giovanissimo Leo Pellegrino), ricorda un ormai defunto padre nell’atto di elargire dettami e raccomandazioni alla sua primogenita, ma siamo certi che ad aver spinto Bey a incidere il pezzo siano stati un paio di versi facilmente adattabili al motivo centrale dell’album (’My daddy warned me about men like you / He said ’baby girl, he’s playing you, he’s playing you’). (7/10)
Lo spiraglio della riconciliazione, così come l’esame di coscienza (´I’ve always been committed, I’ve been focused / I’ve always paid attention, been devoted / Tell me, what did I do wrong?´), comincia a farsi strada nella successiva Love Drought, dove l’espandersi baritono del basso si scontra, delicatamente, con la lucentezza ipnotica dei synths e con il falsetto di Beyoncé sublimato nel ritornello. Un elegante, placido esempio di pop/R&B firmato dall’amico di vecchia data Ingrid Burley e prodotto da Mike Dean, collaboratore assiduo di Kanye West. (8/10)
A seguire, una diade che spazia dalla balladry più struggente e minimale di Sandcastles (6/10) al pomposo incedere gospel/blues di Freedom (introdotta dall’interludio Forward) che, forte di un beat marciante, del rap antipoliziesco di Kendrick Lamar e di un organo estrapolato dalla psichedelica Let Me Try (1969) dei Kaleidoscope (Zalando, Ivy Park, anyone?), cattura la fase catartica e liberatoria dell’album, estesa universalmente a tutti gli uomini e le donne di colore che abbiano subìto torti e discriminazioni nella vita. (8/10)
L’epilogo della vicenda, in stile Omnia vincit Amor, viene sancito infine da All Night, perla del disco che incapsula magistralmente, e in poco più di 5 minuti, tutte le credenziali del feel good tune. Tornano le sonorità reggae (courtesy of Diplo once again), ma rispetto alla precedente Hold Up l’approccio vocale oscilla fra toni grintosi e registri più distesi, sintomo dell’avvenuto riavvicinamento tra marito e moglie. L’eufonìa trasognante del refrain, cadenzata da una voce maschile che ripete il titolo in più punti, eleva al cubo la qualità del brano, mentre la produzione sfiora il culmine della sempreverde gloria funk/soul nel momento in cui attinge ai fiati presi in prestito dagli OutKast.
L’insegnamento morale è servito: il dolore è stato elaborato e l’amore ha trionfato (’With every tear came redemption, and my torturer became my remedy’) (9/10)
Lontana dal nucleo tematico di Lemonade, ma non per questo inferiore, Formation chiude sia l’album che il film (sotto forma di strumentale durante i titoli di coda). Le note rimbalzanti del synth d’apertura, simili alle strimpellate tremule di un banjo elettrico, sono ormai diventate distintive di questo primo e socialmente impegnato singolo che esalta, più che rivendicarlo, l’orgoglio nero (’I like my negro nose with Jackson 5 nostrils / Earned all this money, but they never take the country out me’) attraverso un irresistibile mix di percussioni trap e hip hop suburbano a cura di Mike Will Made It, slang e moduli espressivi attualmente in voga sui social media. (8/10)
Lemonade è disponibile da sabato 23 Aprile su TIDAL e iTunes, e a partire da oggi su formato fisico (via Parkwood Entertainment/Columbia Records).
Ricordiamo inoltre ai nostri lettori che i biglietti per la tappa milanese del Formation World Tour del prossimo 18 Luglio sono attualmente disponibili nei circuiti TicketOne e sul portale ufficiale di Live Nation.